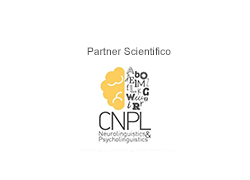SCUOLA
L’esame di Maturità 2020 sarà soltanto un colloquio orale. Per certe ragioni può sembrare una prova “facilitata”, ma in realtà l’esame solo orale presuppone dinamiche diverse e richiede sia da parte degli studenti sia da parte degli insegnanti un impegno diverso.
Il prof. Pietro Viscardi riflette sulle implicazioni di questo “dialogo”, rifacendosi anche alla figura di Ulisse e alla sua sete di conoscenza.
Colloquio è cercare insieme
«Le prove d’esame […] sono sostituite da un colloquio». Questo il succo dell’articolo 16 comma 1 dell’ordinanza del ministero dell’Istruzione circa gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, l’anno del Covid.
Alla notizia alunni e professori, per ragioni diverse, forse si sfregano le mani.
Poi però l’articolo 16 va avanti e dice anche: ci sarà un colloquio nel quale il candidato dovrà dimostrare «di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale». E qui le mani che passano una sull’altra rallentano, si fermano e iniziano a contare: contenuto, metodo, relazione, argomentazione, senso critico, personalizzazione. Come fare?
Ancor prima dell’elenco di questi indicatori c’è un termine, non meno importante, che passa inosservato: colloquio. Riflettendo sull’etimologia (dal latino cum-loqui) ci si accorge che la parola non descrive l’esperienza di un singolo ma esige una pluralità. La responsabilità dell’andamento di un colloquio pertanto non è di un unico individuo, bensì di ogni soggetto partecipante al dialogo (dal greco dia-logos).
Maturità 2020 e colloquio orale: il compito dell’insegnante
Sulle responsabilità (e che responsabilità!) degli alunni l’ordinanza parla chiaro. Mi chiedo allora quali siano quelle di noi docenti. La risposta è semplice: fare domande.
Questo è il compito del docente. È vero, è semplice, ma come tutte le cose vere non è facile. Lo abbiamo visto in questo tempo di didattica a distanza (DAD) dove gli insegnanti, non volendo perdere il rapporto con gli alunni, hanno dovuto smettere di fare richieste e incominciare a fare domande.
La richiesta infatti presuppone una prestazione tutta dell’alunno, dalla quale il docente se ne sta fuori a braccia conserte. La domanda invece chiama in causa entrambi i soggetti: più la domanda è buona più è probabile che lo sia anche la risposta, assumendo magari caratteri così imprevisti da diventare occasione di apprendimento anche per il docente stesso.
In questo periodo ogni maestro con fatica e coraggio ha rovistato nella propria materia per trovarne il cuore da trasmettere. Il lavoro di sintesi non è stato facile. Le conoscenze e le abilità richieste all’esame di maturità sono frutto di questa sintesi, per questo sono parti fondanti dell’esame, ma non sono le uniche.
Il sapere infatti è impastato con il vissuto. Di più: il sapere è il vissuto, un vissuto giudicato. Lo grida il dramma dell’Italia e del mondo che pensavano di sapere tutto della vita e non sapevano nulla. Come diceva Albert Einstein: «L’unica strada per la conoscenza è l’esperienza». Vorremo dimenticarcene quando saremo di nuovo, alunni e docenti, gli uni di fronte agli altri? Quali domande faremo perché il vissuto di ognuno possa emergere?
Leggi anche Esame di stato: la maturità ai tempi del coronavirus
Come si presenteranno i ragazzi davanti ai prof?
Nel terzo libro dell’Iliade si ricorda di quando Ulisse venne in ambasciata a Troia per chiedere la restituzione di Elena. Antenore, presente alla scena, descrive il re di Itaca con lo sguardo chino «in zotica sembianza»: in parole povere, all’apparenza, un poco di buono. Eppure quando l’eroe greco comincia a parlare tutti si meravigliano per le sue «alte parole» e abbandonano l’impressione negativa che avevano avuto di lui.
Pensando alla “zotica sembianza” sorrido immaginandomi i ragazzi, intorpiditi da mesi di reclusione, che si presentano davanti ai prof. Forse riattiveranno il monitor, forse si siederanno ben distanti dai loro docenti e, a domanda, proveranno a rispondere.
Quel nobile consesso che è la commissione d’esame sarà in grado, come avvenne a Troia, di accantonare il suo fondatissimo pregiudizio per far spazio all’imprevisto? Tanto dipenderà dal candidato, ma altrettanto dipenderà dall’assemblea e dalle sue domande.
Narrami l’uomo d’ingegno molteplice, o Musa, che tanto
errò, poi che distrusse la rocca di Troia divina,
vide molte città, di molti uomini l’indole seppe,
e assai patí pel mare, cercando com’egli e i compagni
salva potesser la vita serbare, e tornare alla patria(Odissea di Omero, traduzione Ettore Romagnoli)
Se Ulisse è l’emblema dell’uomo che conosce, che parla in modo convincente perché sa quel che dice, chi deve affrontare una maturità tutta orale non può non sentirsi chiamato a imitarne l’esempio. Ognuno di noi è un Ulisse che vuole conoscere il mondo per conoscere di più se stesso: «Tutto ch’io guardai nel mondo, mi riguardò; mi domandò: Chi sono?», come scriveva Pascoli.
Certo, forse i nostri alunni non avranno visto molte città (soprattutto in questo periodo), non conosceranno bene l’indole umana e a mala pena conosceranno la loro, ma ognuno, in un modo o nell’altro, proverà a dare il nome alle cose. E comunque ognuno, come tutti noi in questi mesi, avrà già patito molto per mare cercando «com’egli e i compagni salva potesser la vita serbare».
Riferimenti:
L’Iliade di Omero, Milano, Milano, BUR – traduzione di Vincenzo Monti
L’Odissea di Omero, Castel Bolognese, Itaca Edizioni – traduzione di Ettore Romagnoli
Pascoli Giovanni, Poemi conviviali, Milano, BUR Rizzoli
Foto di Gustavo Fring da Pexels