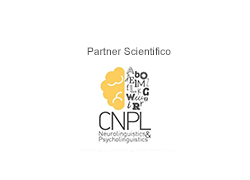BALBUZIE
La balbuzie, definita come disturbo del linguaggio, si riferisce a quelle ripetizioni involontarie di suoni, interruzioni e silenzi che tutti conosciamo. O forse, sarebbe meglio dire, crediamo di conoscere. Perché la prima domanda che è necessario porsi è quando possiamo parlare di balbuzie? Sembra un ossimoro, invece è l’inizio di una scoperta, un viaggio nel mondo di chi l’ha conosciuta e di chi è riuscito a superarla.
Abbiamo rivolto qualche domanda a Valentina Letorio, neuropsicologa del Vivavoce Institute.
Dottoressa Letorio, quando possiamo veramente dire che un bambino balbetta?
Per l’approccio che abbiamo noi, parliamo di balbuzie dopo i 6/7 anni, in età scolare, perché si è riscontrato sulla base di numerosi studi, casi e statistiche presenti in letteratura, che l’età di insorgenza della balbuzie è sì prematura – compare tra il 2 e il 4 anno di età – ma tende a risolversi nella maggior parte dei casi. Di fatto si tratta di un fenomeno molto comune nei bambini piccoli, ma nell’80% dei casi si risolve: è cioè una forma transitoria che recupera spontaneamente.
Possiamo parlare di bambini che hanno cronicizzato il disturbo, a partire dal 6 anno di età. Questa distinzione è importante perché ci fornisce un’indicazione su quando e come intervenire. Si comprende infatti che intervenire prematuramente potrebbe essere controproducente, perché crea ansia e allarmismo tanto nel genitore, quanto nel bambino. Il nostro consiglio è di rivolgersi a uno specialista dal sesto anno di età del piccolo, quando il linguaggio è consolidato, stanno maturando le sue capacità di letto-scrittura e il bambino ha una maggiore consapevolezza di sé e della sua difficoltà.
E allora, quali consigli è bene dare a mamma e papà?
In fase prescolare è bene evitare di intervenire direttamente sul bambino per le premesse anticipate. Piuttosto è opportuno pensare a un percorso di counseling da proporre ai genitori affinché abbiamo le giuste informazioni sul fenomeno: come si può manifestare, se ci sono campanelli d’allarme da tenere d’occhio. In generale si possono adottare delle buone prassi per non far sentire il proprio figlio a disagio, evitando di sovraccaricarlo di ansie, di stimolazioni, di preoccupazioni, e aiutarlo, invece, lavorando insieme sullo stile comunicativo. Imparare a prendersi i propri turni conversazionali, imparare a rispettarli e a farli rispettare, evitare di parlare sul bambino, guardarlo sempre negli occhi senza distogliere il contatto visivo sono aspetti importanti. Allo stesso modo è fondamentale fargli sentire che si è attenti a ciò che dice, non a come lo dice, e guardarlo, dandogli il tempo per esprimersi.
Cosa si sente invece di suggerire a un insegnante?
Si tende a presupporre che gli insegnanti debbano essere preparati su tutto, su ogni situazione in ambito scolastico. Di fatto non è così. Ho visto talvolta preoccupazione e imbarazzo in insegnanti che non riuscivano a capire fino a che punto potessero spingersi per essere d’aiuto senza prevaricare o senza sminuire il lavoro dell’alunno.
Il primo consiglio può essere loro d’aiuto proprio in questa difficile scelta. È importante non pretendere meno dallo studente. Occorre evitare che si adagi pensando che i suoi obiettivi sono diversi da quelli dei compagni. La scuola è soprattutto luogo educativo in cui preparare gli studenti alla vita: non li si può esonerare dal fare, dal provarci perché alcune situazioni potrebbero essere percepite troppo difficili o generare imbarazzo. Un esempio potrebbe essere l’interrogazione. Il ragazzo deve provare e deve capire che non riceve un trattamento diverso perché è balbuziente. Piuttosto sarà utile e efficace collaborare per trovare degli accorgimenti e delle strategie che possano aiutare a superare la difficoltà. Con le classi numerose di oggi può risultare complesso a un docente dare spazio e tempo al suo allievo balbuziente. Tuttavia l’atteggiamento giusto è evitare l’interrogazione scritta e mettere a punto un percorso, magari fuori dall’aula con un compagno la prima volta, per favorire nel ragazzo una presa di coscienza della possibilità di riuscire. Senza trattamenti speciali, ma con la giusta attenzione.
Per concludere, possiamo rispondere alla domanda: balbuzienti si nasce o si diventa?
Anche se non abbiamo ancora maturato certezze sull’eziologia della balbuzie, ci sono evidenze che ci permettono di ritenere che dipendano da fattori genetici. Lo attestano anche le statistiche sulle ricerche nei gemelli omozigoti: le percentuali sono più elevate, perché il disturbo lo hanno entrambi. È poi possibile che un bambino voglia imitare il nonno che balbetta, ma resta un gesto intenzionale che si esaurisce con il desiderio di riuscirci.
Foto: Flickr, Fabio Bretto